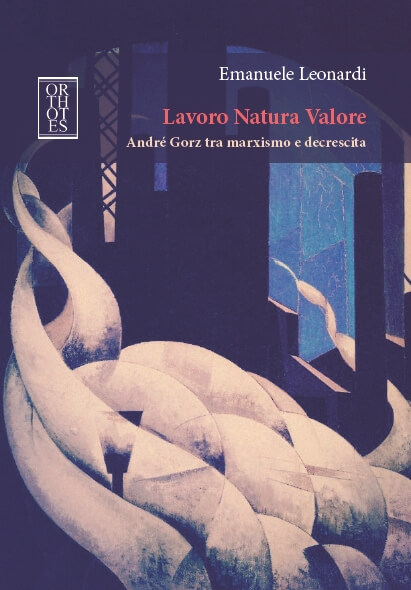Vi proponiamo una lunga intervista a Emanuele Leonardi, autore del libro “Lavoro, Natura, Valore. André Gorz tra marxismo e decrescita”, che abbiamo avuto il piacere di presentare lo scorso anno. Un libro per noi importante per comprendere non solo la crisi ecologica e la sua origine, ma anche per indagare gli spazi politici aperti dai movimenti e dalle lotte territoriali.

- Una parte importante del lavoro contenuto nel tuo libro riguarda la critica al modello della “green economy” e del “carbon trading”. Nella tua ricerca mostri, dati alla mano, come queste strategie si siano rivelate un fallimento nel contrastare la crisi ecologica e i cambiamenti climatici. Tutt’al più hanno rappresentato un’opportunità per il capitalismo odierno di aprire nuovi cicli di valorizzazione proprio a partire da qualcosa che viene comunemente percepito come un limite al mito della “crescita infinita”. Puoi dirci qualcosa in più su questo tema?
La mia ipotesi è che la logica del valore intrattenga con la natura un rapporto duplice, che è bene storicizzare. In un primo momento – rinvenibile con chiarezza nel pensiero degli economisti classici – la valorizzazione capitalistica assume l’ambiente come condizione – infinita e gratuita sia a monte (materie prime) sia a valle (smaltimento dei rifiuti) – del processo economico finalizzato alla produzione di plusvalore, e al contempo pone il lavoro (salariato) come fattore di quello stesso processo, cioè come fonte del valore.
In un secondo momento, successivo alla crisi di questo modello imposta dai movimenti sociali in particolare nel periodo 1968-1973, il capitale si adopera per internalizzare il vincolo ambientale non più come impedimento alla valorizzazione, ma come suo vettore privilegiato. Non si tratta semplicemente di sostituire un ‘nuovo’ nesso valore-natura a quello ‘classico’, bensì di affiancare due diverse modalità di ‘leggere’ l’ambiente dal punto di vista del valore: come limite abilitante nel primo caso, come fonte immediata nel secondo. La green economy, cioè l’idea che si possa disaccoppiare la crescita economica dal throughput (cioè la quantità di materia ed energia che attraversa il sistema produttivo), esprime precisamente il tentativo di esplorare la natura come elemento diretto della valorizzazione. Penso che anche la nostra prospettiva debba mutare secondo queste linee: se la critica dell’economia politica classica intendeva demistificare il tentativo borghese di naturalizzare il capitalismo, la critica ecologica del valore deve oggi saper disarticolare anche il tentativo finanziario di capitalizzare la natura.
Torno alla green economy: si può dire che questa strategia abbia funzionato? La risposta è meno univoca di quanto si creda, perché ci troviamo di fronte a un curioso – e solo apparente – paradosso: dal punto di vista ambientale (quello cioè che ha dato origine al carbon trading) si può tranquillamente affermare che i mercati delle emissioni di gas climalteranti sono inutili quando non dannosi. Essi, banalmente, o non raggiungono gli obiettivi prefissati, o addirittura rendono tale raggiungimento impossibile. Al contempo, dal punto di vista economico, tali mercati rappresentano una miniera d’oro per gli operatori finanziari. In altre parole: nella tensione tra (surrettizi) fini ecologici ed (effettivi) mezzi economici appare con sempre più chiarezza una significativa creazione di valore sotto (inedita) forma di rendita accanto a impatti ambientali nulli quando non deleteri.
Tuttavia, a prescindere dalle valutazioni sui risultati concreti delle politiche improntate alla green economy, vale la pena di notare come essa non sia né falsa né irrazionale: si presenta piuttosto come adeguata all’attuale regime di accumulazione e al contempo come manipolatoria rispetto alla tipologia di lavoro che all’interno di tale regime produce valore. Quasi tutti – in larga maggioranza le popolazioni espropriate dei propri territori, nel Sud come nel Nord globale – ci perdono; pochi – perlopiù gli operatori finanziari – ci guadagnano; nessuno pare interessato a domandarsi che fine abbia fatto il lavoro all’interno del nesso valore-natura che sostiene la green economy. Per riprendere una felice espressione di Toni Negri – applicandola però a un contesto diverso da quello in cui fu concepita – essa si pone come “ragionevole ideologia” della tendenza contemporanea dello sviluppo capitalistico, basata su tre elementi: nuova centralità della sfera della riproduzione sociale, crescente cognitivizzazione del lavoro, assunzione di un ruolo politico fondamentale dei mercati finanziari.
A mio avviso, comprendere le modalità attraverso le quali il lavoro riproduttivo/cognitivo viene assorbito nei e sfruttato dai mercati finanziari è la chiave per indagare la dimensione ecologica della nuova composizione di classe. Cioè: recuperare quel tanto di ragionevole che c’è nella green economy – vale a dire l’idea che la forza lavoro umana possa porsi come eco-fattore positivo e non solo come eco-fattore distruttivo – mostrando come siano precisamente i rapporti sociali capitalistici a rendere inaccessibile quella potenzialità.

- Date queste premesse appare evidente come la crisi ecologica non rappresenti di per sé qualcosa in grado di inceppare i meccanismi dell’accumulazione capitalista. In questo quadro è chiaro come i movimenti sociali giochino una partita fondamentale. In particolare, nel libro, individui nelle lotte territoriali dei conflitti dal grande potenziale anticapitalista. Quali prospettive vedi oggi per queste lotte? Questi soggetti sociali possono essere visti come una nuova classe rivoluzionaria?
In effetti è come dite voi: la ‘teoria del crollo’ riproposta in salsa ecologista non è convincente. Del resto già André Gorz aveva mostrato che il modo di procedere corretto è quello che parte dall’analisi dell’accumulazione per arrivare alla crisi ambientale, poiché quello opposto rischia di portarci in territori parecchio sconvenienti. Scriveva infatti in un’intervista contenuta nella raccolta Ecologica:
“Partendo dalla critica del capitalismo si arriva dunque immancabilmente all’ecologia politica che, con la sua indispensabile teoria critica dei bisogni, conduce di ritorno ad approfondire e radicalizzare ancora la critica del capitalismo […] Se si parte, al contrario, dall’imperativo ecologico si può arrivare tanto a un anticapitalismo verde, a un ecofascismo o a un comunitarismo naturalista (2008: 18).

Seguendo una logica simile, ma trasposta su un piano differente, Luigi Pellizzoni ha sostenuto con ottime ragioni che la disarticolazione del dualismo cartesiano tra materia (res extensa) e pensiero (res cogitans) – da molti ritenuto la causa ‘culturale’ degli scompensi ambientali – non è affatto, in sé e per sé, una cesura netta rispetto alla razionalità politica del capitalismo neoliberale. Una serie di esempi legati ai cosiddetti ‘mercati ambientali’ – non solo carbon markets ma anche forme di pagamento per servizi eco-sistemici, nonché investimenti nella geo-ingegneria e nelle bio-tecnologie – mostrano che è in atto uno slittamento dalla retorica dei limiti alla crescita (che in qualche modo alludeva al degrado ambientale come crisi del capitalismo) a quella della crescita dei limiti (intesi come punti di appoggio per una nuova strategia di accumulazione, che trasforma il vincolo ecologico in una crisi per il capitale).
Ne deriva che il livello della critica deve scendere più in profondità, e per farlo deve trovare “gambe sociali”, ovvero la capacità di saldarsi ai movimenti socio-ecologici e alle lotte territoriali. La loro centralità nello scenario contemporaneo a me pare innegabile. Per spiegarla, nel libro propongo una similitudine provocatoria: come all’inizio del XX secolo il Progresso aveva sempre ragione, anche quando sbagliava, così all’inizio del XXI secolo le lotte socio-ecologiche territoriali hanno sempre ragione, anche laddove alcune loro valutazioni dovessero rivelarsi approssimative. Provo a chiarire: è noto che Filippo Tommaso Marinetti, circa un secolo fa, abbia pronunciato la frase “abbiate fiducia nel Progresso: ha sempre ragione anche quando ha torto, perché è il movimento, la vita, la lotta, la speranza”. Intendeva dire che, qualunque forma avesse assunto questo progresso, i suoi costi sarebbero impalliditi al cospetto dei suoi benefici. Si trattava del resto di un’idea comune a tutti i futurismi: Vladimir Majakovskij scrisse infatti: “dopo l’elettricità non potrei più interessarmi alla natura. Così imperfetta”. Il che, se letto alla luce dell’equazione rivoluzionaria di Lenin – comunismo = soviet + elettrificazione –, significa: il dominio dell’uomo sulla natura per mezzo della tecnica (cioè: sulle forze produttive) rappresenta un valore positivo a prescindere dal progetto sociale cui quel dominio viene orientato (cioè: dai rapporti sociali di produzione). Ecco, io credo che questo quadro di riferimento concettuale fosse, all’inizio del XX secolo – e fino alla crisi del fordismo – sostanzialmente ragionevole. Semplicemente, oggi non è più così.

L’apparente autonomia delle forze produttive, la seduzione tellurica del Progresso poggiavano infatti sulla reale – ancorché parziale – sovrapposizione della logica del valore e della logica delle ricchezze. Ora che il loro crescente divorzio si pone all’osservatore attento come auto-evidenza, i termini del problema mutano: l’intervento politico sulle forze produttive è diventato un elemento essenziale dei rapporti sociali di produzione. Il conflitto non si dà più al livello del mero uso della tecnologia, ma direttamente sul piano delle finalità cui lo sviluppo tecnologico deve orientarsi. È per questo che se anche in futuro un ingegnere meravigliosamente benintenzionato arrivasse a spiegarci che il tunnel del TAV non provocherebbe alcun danno alla salute dei valsusini né all’ecosistema montano – ipotesi assolutamente balzana, va da sé –, ebbene anche in quel caso le ragioni della lotta non verrebbero meno. Questo perché il modello di sviluppo incarnato in quel treno ad alta velocità non ha nulla a che vedere con il concetto di benessere articolatosi nel corso di un conflitto che dura ormai da oltre un quarto di secolo. Insomma: qualunque forma assuma questo ‘progresso,’ i suoi benefici impallidiscono al cospetto dei suoi costi. Questo perché, a differenza di quanto avveniva un secolo fa, il terreno quantitativo non è più quello su cui si comparano costi e benefici. A costi sempre più socializzati si affiancano benefici sempre più privatizzati: è in questa discrasia che la qualità rompe la logica del valore e inaugura la sfera del fuori misura. Il che non significa affatto che non si dia più comparabilità: semplicemente, essa non preesiste i termini del confronto, ma è l’esito di una previa negoziazione tra i soggetti interessati. La logica delle ricchezze non è il regno del relativismo culturale, bensì quello della centralità della mediazione politica tra istanze originariamente incommensurabili.

Mi pare sia giunto il tempo di risalire alle origini della crisi iniziata negli anni Settanta e ripensare il ruolo del lavoro in una società che può finalmente provvedere ai propri bisogni. In altri termini: nelle lotte socio-ecologiche contemporanee si esprime una composizione di classe che non si dà a partire dalla neutralità delle forze produttive, bensì da un loro immediato inglobamento nei rapporti sociali di produzione e nelle lotte che li attraversano. Che tipo di produttori vogliamo essere, in che orizzonte di società vogliamo vivere, quali relazioni vogliamo intrattenere con l’alterità che ci percorre e con quella che ci circonda? Queste sono oggi questioni strategiche, non fantasie da rimandare – eventualmente – a quando il Palazzo d’Inverno sarà stato vittoriosamente assalito.

Questo tuttavia non significa che i movimenti socio-ecologici e le lotte territoriali rappresentino la nuova classe rivoluzionaria. Anzi: credo che essi non si sottraggano alla tendenza generale della trasformazione della composizione di classe, quella che porta all’eterogeneità, come sottolineano a mio parere giustamente Sandro Mezzadra e Brett Neilson. Si tratta dunque di affermare da un lato l’importanza di pensare in termini di classe il rapporto tra politica ed ecologia, e dall’altro di spostare il fuoco della ricerca dal soggetto rivoluzionario ai modi di organizzare la convergenza delle lotte. A questo proposito l’analisi più interessante degli ultimi anni è quella proposta da Salvo Torre in Contro la frammentazione, la cui ipotesi di fondo è la seguente: è sul terreno ecologico che i conflitti sociali del XXI secolo potranno trovare la propria composizione politica. Semplifico brutalmente l’argomento: Torre ritene che la sfida ecologica non sia soltanto un fronte di lotta tra gli altri; essa si presenta anche come tessuto connettivo delle istanze conflittuali che si sono sviluppate in concomitanza con l’espansione del modello neoliberale e che sono deflagrate a partire dalla grande crisi del 2007-2008. C’è un passaggio importante nel libro, che vale la pena di essere riportato: “La potenza espressa nelle esperienze attuali concorre alla definizione generale di un nuovo territorio, il pianeta, e di nuove forme dell’articolazione sociale, le comunità ecologiche […] I conflitti socioecologici non sono dunque una categoria specifica, così come non lo possono più essere i movimenti per la giustizia ambientale, tutti i movimenti hanno una caratterizzazione socioecologica, perché tutti i processi in atto comportano ormai crisi ecologiche e soprattutto perché l’unica alternativa rimasta prevede la riformulazione di un’etica politica del vivente, in opposizione ad un progetto di dissoluzione che non potrà prevalere a lungo” (2017: 85).
Ecco, non sono sicuro che la formula ‘etica politica del presente’ sia quella più efficace, ma non ho dubbi che i movimenti socio-ecologici esprimano molto più un orizzonte di composizione politica per le varie forme di lotta di classe più che la classe rivoluzionaria in sé.
- Come ci dice lo stesso titolo del libro, la tua ricerca si concentra sull’indagare i nessi tra lavoro, natura e valore. In particolare ti soffermi sul carattere entropico del lavoro salariato, che prende forma dalla visione della natura data dall’economia politica classica, concepita come un “condizione infinita e gratuita dell’attività produttiva di valore”. Al carattere entropico del lavoro salariato contrapponi, invece, il carattere “potenzialmente neghentropico” del lavoro riproduttivo, emerso con forza anche grazie alle lotte femministe. Puoi aiutarci a capire meglio questa contrapposizione tra lavoro entropico e lavoro neghentropico, che tu ritieni essere uno dei terreni fondamentali per la lotta di classe nel XXI secolo? Quali potenzialità vedi oggi nei movimenti femministi?
Come accennavo in precedenza l’ipotesi che avanzo nel libro è che il rapporto tra lavoro, natura e valore si modifichi nel tempo. Per definire una prima modalità – il nesso lavoro-natura-valore ‘classico’ – il riferimento d’obbligo è il lavoro del sociologo americano Jason Moore, in particolare il concetto di natura sociale astratta. Esso permette infatti di comprendere i termini specifici attraverso i quali la ‘natura’ viene internalizzata nel processo di valorizzazione come limite abilitante seppur invisibile – cioè: condizione necessaria affinché capitale e lavoro salariato s’incontrino, ma non fattore direttamente coinvolto nell’atto di creazione del valore. Ciò significa che, affinché si dia valorizzazione, le attività vitali di cui la natura è espressione devono essere trasformate in modo tale da risultare conformi alla logica del valore. Ne emerge un quadro che, schematicamente, possiamo riassumere così: il lavoro sociale astratto – cioè forza lavoro salariata, organizzata dal capitale e misurata in unità discrete di tempo di lavoro – è senza dubbio l’unica fonte del valore, situata nella sfera della produzione. Tuttavia, affinché i meccanismi della valorizzazione (che Moore definisce area della mercificazione o della accumulazione per capitalizzazione) possano mettersi in moto, occorre che una gran quantità di lavoro non pagato (quindi non salariato) venga messa a disposizione del capitale. Moore chiama questo movimento accumulazione per appropriazione: esso definisce l’ambito della natura sociale astratta in cui confluiscono in prima battuta gli elementi tradizionalmente relegati alla sfera della riproduzione (lavoro domestico, lavoro servile, doni gratuiti dell’ambiente). Inoltre, la natura sociale astratta comprende le pratiche che rendono ‘visibile’ o ‘quantificabile’, e dunque ‘appropriabile’ o ‘internalizzabile’, la natura come condizione del valore – tra le altre una concezione del tempo lineare/omogeneo e un’idea di spazio piatto e geometrico. In ultimo, questo modello postula l’infinità e la gratuità della sfera della riproduzione.

Tenete conto che, in questa situazione, le possibili linee di conflitto per la classe dei lavoratori salariati sono due: dentro la produzione (contro il capitale e con i soggetti della riproduzione); oppure fuori dalla produzione (con il capitale e contro i soggetti della riproduzione). Semplificando, credo si possa dire che l’approccio social-democratico dei trent’anni gloriosi (approssimativamente 1944-1973) abbia visto il prevalere della seconda opzione. Occorre infatti mettere in luce le due condizioni fondamentali per la tenuta del cosiddetto ‘patto fordista’: la prima fu la crescita economica sostenuta – in termini quantitativi. Seguendo il principio secondo cui aumentando le dimensione della torta tutti i commensali possono mangiare di più, le politiche keynesiane hanno spinto il volume della produzione quanto più possibile verso l’alto, svincolandolo di fatto dai bisogni sociali – favorendone anzi la moltiplicazione non sempre autonoma (bisogni indotti) e la sostituibilità accelerata (obsolescenza programmata). La seconda condizione riguarda lo statuto della sfera riproduttiva all’interno del ‘patto fra produttori’; benché essa fosse certamente coinvolta nei meccanismi di protezione sociale previsti dal welfare state, essa vi entrava in condizione di subalternità: nella sua forma ‘classica’, infatti, il welfare aveva stabilito una particolare relazione con il sistema produttivo: quest’ultimo fungeva da elemento centrale (creazione diretta e distribuzione primaria di ricchezza) mentre il primo agiva da ente periferico (azione redistributiva finalizzata alla tutela individuale e collettiva in caso di fallimento del progetto economico). Se a tale subalternità viene affiancato l’assunto secondo il quale la natura sarebbe infinita e gratuita si comprende agevolmente il motivo per cui il patto fordista può essere considerato un dispositivo entropico: riconoscendo i soggetti della riproduzione come ancillari rispetto a quelli della produzione, e considerando inesauribile la natura-risorsa, ecco che l’obiettivo della crescita quantitativa a ogni costo diviene la premessa indiscutibile di qualsivoglia politica economica. L’inclusione sociale della classe operaia nel Nord globale – un processo di enorme portata storica – avviene a costi alti: la rinuncia all’autonomia nella definizione dei propri bisogni e l’allocazione delle esternalità socio-ambientali negative nella sfera della riproduzione.
È bene comunque sottolineare che, in forma pura, questo patto non è mai stato implementato; ha però funzionato come ideale regolativo del regime di accumulazione fordista e come tale ha profondamente influenzato i rapporti di classe per circa mezzo secolo – almeno nel Nord globale. Inoltre, credo sia fondamentale ricordare che la sua crisi non dipende da fattori economici interni, bensì viene indotta da un fronte plurale di conflitti sociali che hanno luogo sia nella sfera della produzione – mi riferisco da un lato al controllo operaio sul processo lavorativo indagato da Stefania Barca (liberazione del lavoro) e dall’altro al rifiuto del lavoro salariato propugnato dagli operaisti (liberazione dal lavoro) – sia nella sfera della riproduzione – e qui entrano in gioco la rivoluzione femminista, le lotte decoloniali e i movimenti ecologisti.

La convergenza di questi conflitti ha espresso, tra il 1968 e il 1973, il rifiuto della subordinazione cui il modo di produzione capitalistico aveva costretto la sfera della riproduzione sociale. Mi limito qui a un riferimento: la campagna internazionale contro il lavoro domestico. C’è un passaggio bellissimo di Silvia Federici, in un articolo dei primi anni Settanta, che sostanzialmente dice: rivendicare salario per il lavoro domestico non significa chiedere di integrarsi nei rapporti capitalistici ma piuttosto lottare per distruggere il piano del capitale sulle donne. Penso che quella campagna, come altre coeve, abbia subito nel lungo periodo una ‘peculiare sconfitta’: da un lato l’obiettivo centrale non è stato raggiunto, dall’altro però è cambiata radicalmente la base economica dell’accumulazione capitalistica. Bisogna essere ciechi, oggi, per non vedere che i circuiti della valorizzazione non pongono la sfera della riproduzione come ‘esterna’, bensì la inscrivono saldamente al centro dei processi produttivi – su questo punto gli scritti di Andrea Fumagalli e Cristina Morini sono molto importanti. È in questo scenario che avanzo l’ipotesi del lavoro riproduttivo come potenzialmente neghentropico: la politica della riproduzione non richiede né la crescita infinita né l’accumulazione come fine in sé. Da un punto di vista strategico, quindi, si individuano almeno due linee della lotta di classe contemporanea: una di riduzione del lavoro entropico, l’altra di proliferazione del lavoro neghentropico. L’effetto combinato sarebbe quello di una de-mercificazione del lavoro. Del resto aveva ragione Gorz quando sosteneva che il capitalismo contemporaneo mostra con sempre maggiore chiarezza la propria incapacità di far corrispondere alla logica del valore (di scambio) il benessere sociale, cioè una logica delle ricchezze (basata sul valore d’uso). Credo che questa situazione – il divorzio crescente tra valore capitalistico e ricchezza sociale – sia contemporaneamente il frutto del protagonismo della riproduzione nella disarticolazione del patto fordista e il terreno politico di quello stesso protagonismo nella congiuntura presente. Terreno sul quale le strategie di lotta che hanno qualche possibilità di risultare vincenti sono quelle inclusive e intersezionali. E qui si arriva al ruolo fondamentale, oggi, dei movimenti femministi: non per caso è Non una di meno a dettare la linea giusta con la sua capacità di tenere assieme sovversione del patriarcato, lotta di classe e rifiuto della violenza ambientale. Mi pare che dal lavoro di preparazione dello sciopero femminista del prossimo 8 marzo (dopo il grande successo del 2018) emerga l’indicazione di de-mercificare la sfera riproduttiva proprio partendo dalla rivendicazione della sua centralità nella creazione di valore.
- Lungo tutto il tuo libro ti confronti con l’opera di André Gorz, marxista e tra i padri fondatori dell’ecologia politica. Le sue opere le ritieni fondamentali per impostare un dialogo tra marxismo e decrescita, o meglio sarebbe dire tra marxismi e decrescite. Uno degli obbiettivi fondamentali di questa riflessione è quello di affrontare “il problema politico di come produrre conflitto finalizzato alla riduzione della pressione sulla biosfera”. Puoi raccontarci, da un lato, il tuo rapporto con l’opera di questo studioso e, dall’altro, raccontarci il tuo rapporto con la “galassia” dei movimenti per la decrescita.

Ho incontrato l’opera di Gorz per puro caso, nel 2010, e la scintilla s’è accesa subito; tuttavia è stato grazie alla decrescita che mi sono messo a studiare seriamente il suo pensiero. Tutto comincia con il saggio Sette tesi per cambiare la vita (titolo originale Écologie et liberté). Lo adocchiai fortuitamente tra gli scaffali di una piccola ma ricchissima biblioteca del varesotto, mentre scorrevo i vari titoli per rimandare il ritorno al lavoro, e ricordo la sua lettura come uno dei rari momenti appassionanti di quel periodo. Il libro affrontava tematiche molto vicine ai miei interessi di ricerca, ma non si limitava certo a proposizioni analitico-descrittive. Al contrario, si proponeva di aggredire con forza le contraddizioni del proprio tempo: fui contagiato dalla sua carica rivoluzionaria e dalla sua vitalità, dimostrata indirettamente da un dialogo che avrei avuto di lì a poco con Maurizio Pallante (il fondatore del Movimento per la decrescita felice): laddove io individuavo un contributo essenziale al rinnovamento del marxismo, lui scorgeva un esplicito congedo, un taglio netto con la tradizione del materialismo storico. Rimasi inizialmente stupefatto dalla distanza siderale delle nostre interpretazioni, ma finii presto per considerarla un elemento di ricchezza insito nel testo e pensai che una nuova edizione – quella Feltrinelli era fuori catalogo ormai da molti anni – avrebbe potuto rilanciare un dibattito non troppo diffuso in Italia, quello sull’ecologia politica. Sondai questa possibilità all’inizio del 2011, mentre collaboravo con la nascente Orthotes Editrice alla traduzione di The Indivisible Remainder: an Essay on Schelling and Related Matters, di Slavoj Žižek. L’editore sposò l’iniziativa e mosse i primi passi, tuttavia per una serie di ragioni, perlopiù di scarso peso, il progetto non decollò. A posteriori, credo che il motivo principale di quell’inerzia stesse nel fatto che all’epoca riuscivo facilmente a riconoscere la rilevanza teorica del libro, mentre non percepivo l’urgenza politica di una sua re-immissione nel dibattito italiano sulla dimensione sociale della crisi ecologica globale. In quel particolare momento mi pareva facessero difetto sia una comunità allargata di potenziali lettori sia, soprattutto, un orizzonte di composizione tra diverse forme di attivismo, più o meno legate alla questione ambientale. In altri termini: mancava dal mio punto di vista uno spazio politico all’interno del quale soggettività differenti avrebbero potuto articolarsi (anche) attraverso un nuovo accesso alle analisi della ‘fase ecologica’ della ricerca gorziana.
La situazione mutò radicalmente nel settembre del 2014, quando partecipai alla quarta conferenza internazionale sulla decrescita, a Lipsia. Anche in quella circostanza il caso giocò un ruolo non secondario. Avevo attraversato il movimento italiano per la decrescita nella sua fase originaria – tra il 2005 e il 2007 – e me ne ero allontanato per un duplice ordine di ragioni: da un lato quella che ritenevo un’enfasi eccessiva sul tema dei limiti fisici alla crescita (a scapito dei limiti sociali all’accumulazione); dall’altro una certa reticenza a incorporare nella critica ecologica un’analisi di classe del capitalismo contemporaneo. Avevo dunque assistito da lontano, e con una certa dose di scetticismo, alle prime tre conferenze internazionali (Parigi 2008, Barcellona 2010, Venezia 2012). Tuttavia, poco prima che scadesse il tempo utile per inviare una proposta di intervento alla quarta conferenza internazionale, un compagno ‘decrescitista’ mi suggerì di partecipare perché aveva l’impressione che nel movimento stesse emergendo la volontà di esplorare una possibile dimensione ecologica della critica dell’economia politica. Mi incuriosì, spedii l’abstract con incerta convinzione e rimasi indeciso per un po’ se partecipare o meno anche dopo essere stato selezionato. Insomma, non nutrivo grandi aspettative.

E invece fu un’epifania: a fianco di una presenza accademica e giornalistica molto significativa (oltre 500 persone) stava un’enorme quantità di associazioni della società civile, gruppi politici e movimenti di base (oltre 3000 persone). Più che una conferenza fu un festival delle lotte socio-ecologiche, in cui diverse prospettive teoriche e politiche si confrontavano a partire da pratiche determinate – geograficamente e socialmente – che ponevano immediatamente la questione di una convergenza dal basso tra movimenti sociali fino a poco prima indifferenti gli uni agli altri. Cinque giorni di conflitto e discussione sui conflitti, un’effervescenza che non provavo da parecchi anni: avevo trovato lo spazio politico in cui incastonare Écologie et liberté nell’ottica di ‘facilitare’ il riconoscimento e magari un orizzonte di dibattito comune tra marxismi e movimenti per la decrescita. Insomma, molto era cambiato rispetto allo scetticismo del 2007: certamente il mio punto di vista, fattosi più aperto e curioso; poi una perdurante insoddisfazione nei confronti di ciò che Mezzadra ha definito “progressismo implicito” dell’operaismo (che ciononostante rimane la mia “casa teorica”); infine, la composizione del campo della decrescita era mutata, in particolare con l’emergere di quella che ho definito la sua ‘via catalana’, cioè un gruppo di studiosi e militanti meno restii ad affrontare la dimensione sociale della crisi ecologica anche in connessione con le tradizioni rivoluzionarie della modernità – anarchismo e marxismo, soprattutto. Su questo punto mi permetto di insistere un attimo perché lo ritengo importante: chi, nel 2019 – e dopo sei conferenze internazionali (le ultime due sono state Budapest 2016 e Malmö 2018) – parla di decrescita al singolare lo fa probabilmente per screditare questo campo di riflessione e attivismo. Il termine ‘decrescita’, infatti, può (e dovrebbe) essere spacchettato in almeno due modi: il primo è per così dire ‘geografico’ (per esempio, chi si identifica come ‘decrescitista’ in Germania tende a prendere parte alle azioni dirette per la giustizia ambientale e climatica, mentre in Italia tende a partecipare alle esperienze di economia solidale). Il secondo modo è più ‘contenutistico’: la decrescita designa infatti contemporaneamente uno slogan provocatorio (Latouche), un movimento sociale prevalentemente europeo che riprende le tematiche della giustizia ambientale (Martinez-Alier) e infine un progetto di ricerca ampio e plurale che impegna un numero crescente di accademici militanti (D’Alisa, Demaria e Kallis). Per quanto mi riguarda, credo che il primo elemento sia stato importante ma abbia ormai esaurito la sua spinta propulsiva. Ritengo invece che il secondo rappresenti una componente interessante dell’odierno mosaico delle forze anti-capitaliste (con cui la mia ‘casa politica’, cioè in senso molto generale quel che rimane della scena dei Centri Sociali, farebbe bene a rapportarsi). Per quanto riguarda infine il terzo elemento, posso tranquillamente affermare di sentirmi parte integrante di esso (per non fare che un esempio, sono stato membro del comitato scientifico dell’ultima conferenza internazionale).

Torniamo a Lipsia e al 2014: rientrato in Italia, contattai l’editore per sincerarmi che l’interesse per Gorz non fosse scemato e, una volta rassicurato, mi misi al lavoro: nel giro di pochi mesi Ecologia e libertà era di nuovo in circolazione. La mia impressione è che, pur nella consapevolezza dei limiti dell’iniziativa, l’obiettivo della nuova edizione – cioè il riannodarsi del filo del dialogo tra alcuni marxismi interessati alle tematiche ecologiche e alcune aree del movimento per la decrescita – possa considerarsi raggiunto. In questo quadro, lo scopo dell’ultimo capitolo di Lavoro Natura Valore è quello di intervenire in quello spazio dialogico con una formulazione autonoma: essa si riannoda alla trasformazione epocale del nesso lavoro-natura-valore richiamato sopra e indica la necessità di ripensare la divisione politica del lavoro che aveva contraddistinto le prime prove di avvicinamento tra materialismo storico anti-determinista (Marx/Gorz) e proto-decrescita (Georgescu-Roegen/Illich). Tale divisione del lavoro si installava in ultima analisi sull’idea che lo shock petrolifero del 1973 avesse sprigionato una duplice crisi, contemporaneamente sociale (o di sovrapproduzione) e ambientale (o di riproduzione). In questa situazione, lo spazio di una coalizione possibile si dava per così dire immediatamente: benché permanessero differenze significative rispetto all’individuazione della causa prima della crisi (caduta tendenziale del saggio di profitto/lotte operaie oppure violazione dei limiti ecologici?), si trattava comunque di criticare il capitalismo da posizioni convergenti (per così dire da dentro e da fuori rispetto al rapporto di capitale).
La sconfitta ‘peculiare’ della cosiddetta ‘stagione dei movimenti’ (1968-1977) ha mostrato l’insufficienza di questa alleanza interamente ‘addizionale’ tra marxismo e proto-decrescita, ma a mio avviso non ne ha certificato il completo superamento. Anzi: il proliferare a ritmi sempre più sostenuti della violenza extra-economica del capitalismo contemporaneo – per un verso l’accumulazione per spoliazione proposta da David Harvey, per l’altro l’accumulazione per contaminazione discussa da Giacomo D’Alisa e Federico Demaria – ripropone con ancora più forza il problema della pressione del processo di valorizzazione sull’ecosistema. Accanto a tutto ciò, però, emerge la novità costituita da quell’ambito del nesso lavoro-natura-valore che vede l’ambiente entrare direttamente nella valorizzazione in quanto fattore (e non più condizione) della produzione, in quanto espressione del general intellect e della sfera della riproduzione, cioè del lavoro-informazione e della cura dei beni comuni. In altri termini, si pone il problema politico di come produrre conflitto finalizzato alla riduzione della pressione sulla biosfera (diminuzione del lavoro entropico, cioè riduzione o ‘snellimento’ del metabolismo sociale) e alla proliferazione delle attività di cura e produzione di conoscenza e società (moltiplicazione del lavoro neghentropico). Proprio sul lavoro neghentropico dovrebbe infatti basarsi ciò che Nina Power ha definito “de-capitalizzazione” [decapitalism], vale a dire una strategia di lotta che aggredisca il capitalismo contemporaneo senza accettare l’aut-aut tra ottimismo accelerazionista e auto-castrazione antimoderna.
Essendo fondamentalmente legato al general intellect, il lavoro neghentropico non può che installarsi su di un paradigma tecno-economico di stampo digitale: solo da quella prospettiva diviene possibile politicizzare la sostenibilità in modo tale che una conoscenza sociale non mercificata possa porsi al servizio della protezione ambientale. Non si tratta certo di pensare che le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in quanto tali, possano ‘risolvere’ la questione ecologica: allo stato attuale delle cose i loro requisiti energetici non sono compatibili con un pianeta in salute. Resta tuttavia possibile lottare per un nesso lavoro-natura che si situi al di là della logica del valore, cioè per costruire rapporti di produzione che privilegino lo sviluppo autonomo del lavoro neghentropico rispetto agli imperativi dell’accumulazione capitalistica. Tali rapporti dovranno diventare il terreno su cui edificare un modo di produzione sempre più basato su reti gratuite peer-to-peer legate alla cura dei beni comuni e alla sostenibilità ambientale.
Un’ultima notazione riguardo al rapporto con l’opera di André Gorz: nel libro non si troverà alcuna ricostruzione sistematica della sua traiettoria socio-filosofica – la biografia di Willy Gianinazzi (André Gorz, une vie) e il libro di Françoise Gollain (Une philosophie de l’émancipation) soddisfano perfettamente la necessità di un solido quadro esegetico. Il mio tentativo è invece quello di utilizzare l’opera di Gorz come guida concettuale per riflettere su alcuni problemi strettamente legati all’attualità: i passaggi ‘gorziani’ del mio libro sono sempre mischiati a suggestioni provenienti da altre tradizioni politico-culturali, secondo una logica che si giustifica unicamente nel rapporto tra la questione affrontata e la volontà di comprenderla adeguatamente per aggredirla politicamente. Inoltre, sarei felice se fossi riuscito ad assumere la ‘postura’ di Gorz – quella del costruttore di ponti: provo un’ammirazione senza limiti per la sua capacità di promuovere dialogo e mutuo riconoscimento tra anime anche distanti dell’anti-capitalismo. È anche – forse sopratutto – questo suo stile di militanza che occorrerebbe riscoprire, a dieci anni dalla morte (sua e di Doreen, la compagna di tutta una vita).